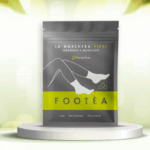L’infarto STEMI rappresenta una delle emergenze cardiologiche più gravi e richiede un riconoscimento rapido per ridurre il rischio di danni permanenti o morte. La sigla STEMI deriva dall’inglese “ST-Elevation Myocardial Infarction” e indica un infarto miocardico acuto caratterizzato da un tipico sopraslivellamento del tratto ST all’elettrocardiogramma, segno di un’ischemia intensa e profonda a livello del muscolo cardiaco. Il meccanismo fisiopatologico principale è l’occlusione acuta e completa di un’arteria coronarica, causata solitamente dalla formazione di un trombo che improvvisamente blocca il flusso sanguigno destinato al cuore.
Come si manifesta e perché è così pericoloso
Un infarto miocardico acuto come lo STEMI ha conseguenze molto rapide e potenzialmente devastanti. L’arresto del flusso sanguigno comporta l’ischemia miocardica transmurale, ovvero il mancato apporto di ossigeno a tutto lo spessore della parete cardiaca irrorata dall’arteria ostruita. Senza un intervento tempestivo, questo processo evolve in necrosi, cioè morte cellulare irreversibile, con danni più o meno estesi in base al punto in cui si è verificata l’occlusione e al tempo trascorso prima della riperfusione.
La gravità dello STEMI è legata all’arresto totale del flusso nel territorio colpito: più l’ischemia si prolunga, maggiore sarà l’estensione dell’area danneggiata e più difficile sarà il recupero della funzione cardiaca. Questo tipo di infarto, dunque, si distingue per la sua urgenza: ogni minuto conta, perché la perdita di tessuto miocardico può tradursi in insufficienza cardiaca, aritmie maligne e morte improvvisa.
Secondo i dati epidemiologici, il tasso di mortalità per STEMI resta elevato, nonostante i progressi degli ultimi anni; l’entità del rischio dipende anche dall’età, dal tempo di intervento e dalla presenza di fattori di rischio cardiovascolari. L’infarto miocardico acuto rappresenta ancora oggi la principale causa di morte nelle società occidentali e anche nei Paesi in via di sviluppo, sottolineando l’importanza della prevenzione e della rapidità nell’agire di fronte ai sintomi sospetti.
I sintomi chiave dello STEMI
Uno degli aspetti più insidiosi dell’infarto STEMI è che i sintomi non sono sempre facilmente riconoscibili; tuttavia, alcuni segnali sono tipici e dovrebbero far scattare l’allarme:
- Dolore toracico intenso e prolungato: è il sintomo più comune. Viene spesso descritto come una pressione, un peso o un senso di costrizione (“morsa”), localizzato al centro o al lato sinistro del petto. A differenza dell’angina pectoris stabile, il dolore non regredisce a riposo o con l’assunzione di farmaci.
- Diffusione del dolore: può irradiarsi a spalla, braccio sinistro, collo, mandibola o schiena.
- Sudorazione profusa, spesso fredda.
- Nausea, vomito o dolore epigastrico (zona dello stomaco).
- Dispnea, ovvero difficoltà a respirare e senso di fiato corto.
- Debolezza improvvisa, senso di malessere generale, sincope o perdita di conoscenza nei casi più gravi.
- Alcuni pazienti, specie donne, anziani e diabetici, possono presentare sintomi atipici come astenia marcata, vertigini, palpitazioni o solo mancanza di fiato.
È importante ricordare che la sintomatologia può essere variabile: mentre il dolore toracico resta il segnale d’allerta più frequente, in una parte dei casi si manifestano solo segni generici che potrebbero essere sottovalutati sia dal paziente che dal personale non specializzato.
Fattori di rischio e prevenzione
Lo STEMI si sviluppa in presenza di una preesistente coronaropatia, cioè di placche aterosclerotiche che restringono le arterie coronarie. Alcuni fattori di rischio favoriscono la formazione e l’instabilità delle placche:
- Età
- Sesso maschile
- Ipertensione arteriosa
- Colesterolo alto
- Diabete mellito
- Fumo di sigaretta
- Obesità e sovrappeso
- Sedentarietà
- Storia familiare di malattie cardiovascolari
- Abuso di alcolici
L’intervento su questi fattori attraverso una prevenzione primaria, cioè uno stile di vita sano e controlli regolari, può ridurre significativamente le probabilità di andare incontro a un infarto acuto con sopraslivellamento del tratto ST. Modificare l’alimentazione, praticare attività fisica, controllare la pressione e i valori di glucosio e colesterolo, smettere di fumare e ridurre il consumo di alcol sono strategie riconosciute e raccomandate a livello internazionale.
Nel caso si manifestino i sintomi sopra descritti, è fondamentale attivare immediatamente i soccorsi (chiamare il 112 o 118) e non tentare di recarsi al pronto soccorso con mezzi propri. Ogni minuto di ritardo può compromettere il successo delle terapie di riperfusione e la sopravvivenza del paziente.
Diagnosi e terapie di emergenza
La diagnosi di STEMI si basa su:
- L’esame clinico e la valutazione dei sintomi.
- L’esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG), che evidenzia il tipico sopraslivellamento del tratto ST che dà il nome all’evento patologico.
- La misurazione degli enzimi cardiaci (troponina e CK-MB) nel sangue, indice di danno miocardico.
L’obiettivo del trattamento è ristabilire rapidamente il flusso sanguigno nell’arteria ostruita (riperfusione), riducendo al minimo l’area di necrosi. Le terapie di prima scelta sono:
- Angioplastica coronarica primaria (PCI primaria): procedura invasiva che prevede la dilatazione dell’arteria con un palloncino e l’inserimento di uno stent. È oggi il trattamento raccomandato, se disponibile entro 90-120 minuti dall’esordio dei sintomi.
- Terapia trombolitica: farmaci che sciolgono il trombo, utilizzati quando l’angioplastica non è praticabile in tempi rapidi.
A queste si aggiungono terapie farmacologiche complementari, come antiaggreganti, anticoagulanti, betabloccanti e statine, oltre a un monitoraggio intensivo.
Negli ultimi anni, la mortalità e l’incidenza di danni permanenti hanno subito una progressiva riduzione grazie alla diffusione dell’angioplastica primaria e dei centri specializzati. Tuttavia, il successo terapeutico è legato in modo diretto alla precocità dell’intervento: la rapidità con cui si riconoscono i sintomi e si arriva al trattamento può fare la differenza tra la vita e la morte, tra un recupero completo e una disabilità permanente.
In sintesi, la conoscenza dei segnali di allarme e dei fattori di rischio è il primo passo per ridurre l’impatto dello STEMI sulla popolazione. La prevenzione e l’informazione rivolta a tutta la cittadinanza sono essenziali per salvare vite umane e limitare le conseguenze di questa patologia tanto temuta.